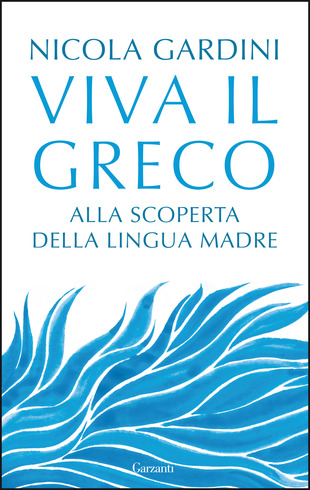La Grecia antica è a un tempo inizio e punto d’arrivo. Nella sua lingua si sono elaborati i fondamenti stessi della nostra civiltà, all’insegna di altissimi ideali come la giustizia e l’amicizia.
I racconti eroici di Omero hanno trasmesso un’etica dell’eccellenza; la lirica di Saffo ha rappresentato i travagli e le gioie dell’eros; quella di Pindaro ha esaltato le glorie della competizione atletica; le storie di Erodoto e Tucidide hanno indagato le differenze tra i popoli e i motivi dei conflitti.
E ancora: le tragedie di Eschilo, Sofocle ed Euripide hanno portato in scena il dramma della libertà individuale; le commedie di Aristofane hanno criticato le derive della democrazia e posto in primo piano la formazione dei giovani; i dialoghi di Platone hanno dato voce alle ambivalenze del reale; i discorsi di Demostene hanno insegnato a difendere la libertà dalle sopraffazioni più temibili…
Dopo averci iniziato all’utile inutilità del latino nel bestseller Viva il latino. Storie e bellezza di una lingua inutile (Garzanti), Nicola Gardini, classe 1965 e dal 2020 presidente della casa editrice Salani, volge ora lo sguardo alla mitica patria ideale e in Viva il greco. Alla scoperta della lingua madre (Garzanti) ci accompagna alla scoperta di una lingua di infinita ricchezza, fitta di contrasti e di parallelismi, costruita sul confronto e sull’antitesi, che ancora può aiutarci a interpretare la complessità dei nostri tempi, invitando a comporre i dissidi in convergenze.
L’autore, che ha pubblicato anche alcuni articoli su ilLibraio.it, insegna Letteratura italiana e comparata all’Università di Oxford e, sempre con Garzanti, ha pubblicato anche Con Ovidio, Le 10 parole latine che raccontano il nostro mondo e Il libro è quella cosa.
Per gentile concessione della casa editrice, su ilLibraio.it pubblichiamo un capitolo del libro:
5. LE PAROLE DEL SOTTOSUOLO
La morte e i morti
Restiamo ancora un po’ con l’Odissea e soffermiamoci sulla parte dell’oltretomba, che costituisce il cuore della narrazione, oltre che di per sé uno dei momenti più emozionanti e più affascinanti dell’intero poema. Omero entra nel mistero dei misteri, e ce lo rappresenta. Se ne potrebbe parlare per moltissime pagine, e da molteplici punti di vista. Potrei anche farne un altro esempio della “separatezza” di Odisseo – lui il solo vivo. Qui, però, voglio considerare l’oltretomba in un’ottica più ampia.
Delle molte contrapposizioni su cui si è organizzata la cultura greca quella tra vita e morte ha importanza suprema. Ho detto “vita” e “morte”, ma dovrei dire più esattamente “vivi” e “morti”. Un’idea astratta di morte manca ai greci. Loro, anziché di morte, parlano di morti. La morte, certo, ha caratteristiche generali: è ineluttabile, non fa eccezioni, porta pena e pianto. Non è, però, concepita fuori dai casi in cui gli individui la incontrano. La morte, per i greci, è sempre la morte di qualcuno. Ognuno è la sua propria morte. La morte e il morto sono una sola cosa. Parimenti la vita e il vivo. E proprio questa personalizzazione sia della vita sia della morte permette che tra vivi e morti esistano rapporti, confronti, incontri. Se interviene divisione o, piuttosto, distanza, questo non significa che sia abolita qualunque possibilità di contatto tra gli uni e gli altri. I morti e i vivi, dunque, pur sempre in date circostanze, interagiscono; dialogano. Le capacità linguistiche dei morti sono, appunto, quel che più mi interessa.
L’aggettivo thespésios e Tiresia
Istruito da Circe, nell’undicesimo libro dell’Odissea Odisseo attraversa l’Oceano, arriva nella terra dei Cimmeri e con la spada scava sulla spiaggia una buca (bóthros, βόθρος) di mezzo braccio di lato. Dopo aver compiuto le libagioni rituali, sgozza le bestie e inonda del loro sangue la buca, agendo da vero e proprio negromante, come è stato osservato.6 I morti, attirati dal sangue, salgono dall’Erebo, cioè da sottoterra (hypèx Erébeus, ὑπὲξ Ἐρέβευς, v. 37), e si accalcano intorno alla buca. Nel canto ventiquattresimo della stessa Odissea, dove il racconto ritorna nell’Erebo, la sede dei morti è indicata dalla perifrasi hypò keúthesi gaíes (ὑπὸ κεύθεσι γαίης, v. 204), “nelle profondità della terra” (espressione che già compare in Iliade XXII, 482 in bocca ad Andromaca, rivolta a Ettore appena ucciso).
Non sentiamo subito parole articolate, ma “gridi tremendi”: thespesíei iachêi (θεσπεσίῃ ἰαχῇ, v. 43). L’aggettivo thespésios (θεσπέσιος) vuol dire anche “oracolare”, “fatidico”; e questo significato, se anche non definisce specificamente il sostantivo iachêi, proietta le sue risonanze sull’intero canto. Odisseo, infatti, è venuto fin qui per interrogare l’indovino Tiresia sul proprio futuro.
Prima, però, parla con l’ombra del compagno Elpenore, che è morto cadendo dal tetto di Circe, dove si era addormentato ubriaco. Elpenore racconta in dettaglio la sua sventura a Odisseo, e infine lo prega di dare sepoltura al suo corpo, e Omero non perde occasione per dire che “parlava molto”, póll’ agóreuen (πόλλ’ ἀγόρευεν, v. 83). Teniamolo a mente: i morti parlano volentieri.
Ma veniamo a Tiresia. Ho già detto che dai morti ci aspettiamo verità. Tiresia dichiara questo ben tre volte:
- all’inizio della sua profezia: “ch’io ti dica il vero”, toi nemertéa eípo (τοι νημερτέα εἴπω, v. 96);
- alla fine della sua profezia: “queste cose vere ti dico”, tà dé toi nemertéa eíro (τὰ δέ τοι νημερτέα εἴρω, v. 137);
- quando dice a Odisseo che chiunque abbia a ricevere da lui il permesso di avvicinarsi alla fossa “gli dirà il vero”, ho dé toi nemertès enípsei (ὁ δέ τοι νημερτὲς ἐνίψει, v. 148).
La profezia di Tiresia ci rivela cose che esorbitano dallo spazio del poema. Odisseo tornerà a casa e ucciderà i proci – e di questo troveremo il racconto nei libri successivi. Un giorno, però, dovrà ripartire, arrivare in una terra che non conosca la navigazione, lì piantare il remo; a quel punto ritornerà nuovamente a casa, invecchierà e troverà la morte in mare. Di tutto questo, che avviene dopo la strage dei proci, il poema non fornisce alcun resoconto cronologico. Ne siamo informati solo nella previsione dell’indovino. Gli eventi che Tiresia profetizza, infatti, resteranno sempre futuri per il lettore. La cosa non è solo di importanza narratologica, ma ha anche un’implicazione più latamente culturale: vale a dire, lo spazio della morte è un’estensione di quello della vita e i due si collegano attraverso la parola.
La madre e il verbo oîda
Tocca poi alla madre, Anticlea. Odisseo la invita a parlargli con l’imperativo eipè (εἰπὲ), “di’”, “parla”, ripetuto tre volte (vv. 170, 174, 177). Lei gli racconta la propria fine, gli spiega l’immaterialità degli spiriti dopo che Odisseo ha vanamente tentato di abbracciarla tre volte, e a sua volta lo invita a dire, cioè a riportare, una volta tornato nel mondo dei vivi, quel che ha visto. Le parole del sottosuolo, infatti, sono non solo quel le dei morti, ma sono anche quelle di chi, come Odisseo, i morti li ha incontrati e ascoltati:
ma cerca di tornare al più presto alla luce; e tutto questo osserva, per poi ridirlo a tua moglie.
ἀλλὰ φόωσδε τάχιστα λιλαίεο. ταῦτα δὲ πάντα ἴσθ’, ἵνα καὶ μετόπισθε τεῇ εἴπῃσθα γυναικί.
(Odissea XI, 223-224)
Vorrei sottolineare la presenza del verbo ísthi (ἴσθ’ι): imperativo del verbo oîda (οἶδα). Qui mi si permetta una minima incursione nella grammatica. Oîda è il perfetto del verbo horáo (ὁράω), “vedo”. Da “ho visto” questo perfetto passa assai presto a significare esclusivamente “so”. In Omero i significati coesistono ancora, e possono anche sovrapporsi, come in questi versi. Vedere i morti, infatti, porta conoscenza, una conoscenza superiore, che va custodita e poi condivisa con la compagna di vita. Anticlea, insomma, investe il figlio Odisseo di una missione oracolare. Interessante è che la comunicazione di quella conoscenza superiore abbia per motore e per destinatario due donne, la madre e la moglie.
Le donne, d’altra parte, hanno gran peso in questo libro undicesimo: eroine che si fanno avanti e si presentano, pronunciando le proprie origini. Più interessante, però, è la parte degli eroi, che segue dopo una pausa del racconto. Ne vediamo sfilare parecchi, ma l’attenzione del poeta si fissa in particolare su quattro: Agamennone, Achille, Aiace ed Eracle.
La lezione di Agamennone
Agamennone racconta di esser stato ucciso dalla moglie, Clitemnestra, una volta rientrato da Troia. E mette Odisseo in guardia contro le donne:
e non rivelarle ogni parola che tu sappia, ma di’ una parte, l’altra invece resti nascosta.
μηδ’ οἱ μῦθον ἅπαντα πιφαυσκέμεν, ὅν κ’ ἐῢ εἰδῇς, ἀλλὰ τὸ μὲν φάσθαι, τὸ δὲ καὶ κεκρυμμένον εἶναι.
(Odissea XI, 442-443)
Torna il verbo oîda; questa volta al congiuntivo: eidêis (εἰδῇς), “sappia”. Agamennone consiglia a Odisseo pure di approdare di nascosto (krýbden, κρύβδην, v. 455). L’esperienza l’ha reso sospettoso, guardingo, seppure ormai per l’esclusivo vantaggio di altri. Vorrei sottolineare che Agamennone offre i suoi consigli con la chiara consapevolezza di aver cose importanti da dire:
altro ti voglio dire […]
ἄλλο δέ τοι ἐρέω […]
(Odissea XI, 454)
Dei morti è lui, Agamennone, quello che in maniera più evidente fa della parola, non profetando, ma ricordando, un ponte tra vita e morte, e dalla morte pretende di influenzare la vita.
Segue l’incontro con Achille, il più celebre del libro. Achille è la voce del rimpianto e della nostalgia. Chiede del figlio Neottolemo e del padre Peleo, e non nasconde che, pur di uscire dal grigiore della morte, preferirebbe essere l’ultimo degli uomini. L’atteggiamento tutt’altro che eroico dell’eroe Achille – contro cui si pronunciano con uguale fastidio tanto Platone quanto Luciano – ha goduto di tale successo da passare per paradigma dell’idea greca di oltretomba. In realtà non è esattamente così. Altre fonti, Platone stesso incluso (che tratta dell’oltretomba nel Gorgia, nel Fedone e nella Repubblica), ci dicono che di là si può anche stare benissimo. Ma non è qui il caso di entrare in una questione che ci porterebbe fuori dal tema del capitolo.
Achille, diversamente dai precedenti interlocutori di Odisseo, non ha verità da comunicare. La sua tristezza sta proprio nel fatto che da morto non sa darsi alcun ruolo pedagogico. Odisseo gli risponde solo a proposito del figlio, poiché sul padre non è informato, come ammette. Gli dice che è buon parlatore e che si è comportato da valoroso. Omero approfitta dell’occasione per mettere in bocca a Odisseo il racconto del cavallo di Troia, di cui non si fa menzione nell’Iliade. A questo punto la professione di verità è completamente passata dai morti a Odisseo stesso. E di questo Odisseo è ben consapevole. Prima di rispondere ad Achille, infatti, dice:
tutta la verità dirò, come mi chiedi
πᾶσαν ἀληθείην μυθήσομαι, ὥς με κελεύεις
(Odissea XI, 507)
Qui, anziché nemertéa, troviamo aletheíen (ἀληθείην, da alétheia, ἀλήθεια), “verità”, uno dei vocaboli più celebri della lingua greca (formato da alfa privativo e dalla radice del verbo lantháno, λανθάνω, “celarsi”).
Se Achille non ha alcuna verità da esprimere, Aiace si rifiuta addirittura di parlare. È adirato con Odisseo, che gli ha sottratto le armi di Achille, spingendolo al suicidio. In realtà, qualcosa dice, ma apre la bocca solo dopo essersi allontanato (v. 565), e a noi non giunge parola.
Ultimo, dopo una rapida passerella d’altri eroi, prende la parola il simulacro di Eracle (simulacro di un simulacro, dato che Eracle è assunto in Olimpo tra i numi). Lui ricorda a Odisseo che è figlio di Zeus e che rapì Cerbero. Tutto qui. Via via che il libro si avvicina alla fine gli incontri sbiadiscono; i messaggi perdono sostanza. Prima che Eracle cominci a dire si odono stridi come di uccelli, le voci dei morti (v. 605). E dopo che ha parlato si odono rumori tremendi, echêi thespesíei (ἠχῇ θεσπεσίῃ, v. 633). Si era partiti in modo analogo, thespesíei iachêi (θεσπεσίῃ ἰαχῇ, v. 43): l’aggettivo ora torna a suggellare la circolarità della chiusa.
La morte e la vita
L’oltretomba, come ho già accennato, ritorna nel ventiquattresimo libro. Qui vediamo le anime dei proci discendervi, dietro a Ermes:
[…] e quelle [le anime] seguivano. Come quando i pipistrelli nel cupo di un antro tremendo squittendo svolazzano, dopo che uno si sia staccato dalla fila giù della roccia, e si riattaccano l’uno all’altro, così squittendo quelle andavano insieme […]
[…] ταὶ δὲ τρίζουσαι ἕποντο. Ώς δ’ ὅτε νυκτερίδες μυχῷ ἄντρου θεσπεσίοιο τρίζουσαι ποτέονται, ἐπεί κέ τις ἀποπέσῃσιν ὁρμαθοῦ ἐκ πέτρης, ἀνά τ’ ἀλλήλῃσιν ἔχονται, ὣς αἱ τετριγυῖαι ἅμ’ ἤϊσαν […]
(Odissea XXIV, 5-9)
Riecco il nostro aggettivo thespésios (qui nella forma thespesíoio, θεσπεσίοιο). L’ho tradotto ancora una volta con “tremendo”, ma la presenza dei morti fa agire certamente anche l’altro significato, quello di “fatidico”.
In questo ultimo libro i morti non devono rispondere ad alcun visitatore vivente, ma parlano tra loro. E di che cosa parlano? Della propria fine. Ritroviamo Achille e Agamennone, e incontriamo l’anima di Anfimedonte, uno dei proci. Achille compiange Agamennone per la sua morte ingloriosa, Agamennone ammira quella di Achille, e la rievoca – e così ancora una volta l’Odissea ci mette davanti un’estensione testuale, nella fattispecie un episodio della guerra troiana che l’Iliade non ha incluso. Ed elogia la virtù di Penelope. Anfimedonte, da parte sua, racconta gli inganni di Penelope, il ritorno di Odisseo, la gara dell’arco e la strage; in pratica, fa un riepilogo del poema, o almeno di una certa parte, dandoci un’ulteriore prova di quel simbiotico nesso che lega vita e morte e che ha nella parola poetica la sua sostanza.
(continua in libreria…)
Fonte: www.illibraio.it