Di libri sugli Stati Uniti sono pieni gli scaffali, che raccontano le metropoli sulle coste, le sterminate pianure, i laghi degli stati del nord e le paludi di quelli del sud.
A ogni nome e ogni titolo ne viene in mente per assonanze o discrepanze un altro. Gli Stati Uniti, come il nome che portano, sono plurali, crocevia di innovazione e conservatorismo, di migrazioni da Paesi ben al di fuori dei loro confini e razzismi feroci: la competizione elettorale tra Kamala Harris e Donald Trump ha riacceso, come ci aspettavamo, tutti questi discorsi, una discussione che si era appena attenuata.
Quella che troverete qui, allora, non è una lista di “libri per capire gli Stati Uniti”, non è una lista di “libri fondamentali in vista delle elezioni”, ma uno spunto, una finestra, o meglio un insieme di finestre affacciate sulle diverse angolature di uno stesso paesaggio. Che sia idilliaco o in fiamme, sta a chi legge valutarlo.
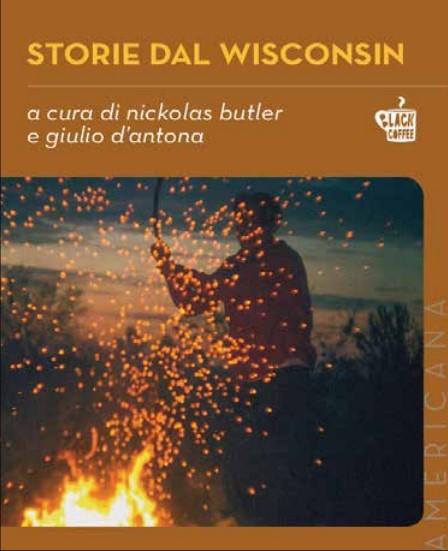
Comunità e isolamento: questi due opposti sono in costante dialogo nella raccolta curata da Nickolas Butler e Giulio D’Antona per Black Coffee, Storie dal Wisconsin, un insieme di testi memoiristici (ma con un importante impianto narrativo), scritti da autrici e autori – come dice il titolo – che nel Wisconsin hanno mosso i primi passi o ci sono arrivati, come Lopamundra Basu, nata a Calcutta. Autori che, come spesso accade negli Stati Uniti, vengono da realtà diverse, che scrivono per mestiere o per passione, mentre fanno altri lavori: costruire barche, curare i campi. Comunità, dicevamo, a cui forse siamo abituati anche nella provincia europea, con gli stadi in cui guardare le squadre locali, in questo caso il football dei Green Bay Packers, oppure isolamento, come quello scelto da Jay Gilbertson, che decide di comprare con il marito un casolare su un romantico declivio collinare, oppure come quello che si avverte dall’abitacolo di un automobile, quando si è costretti a guidare in una tempesta di neve. Un isolamento che la comunità invade sempre gentilmente, accorrendo in aiuto quando la tua casa brucia e devi tirarne su una nuova, o quando le ruote della macchina restano impantanate nella neve di un vialetto. Sullo sfondo, la natura americana, splendida e terribile, che tutto democratizza.
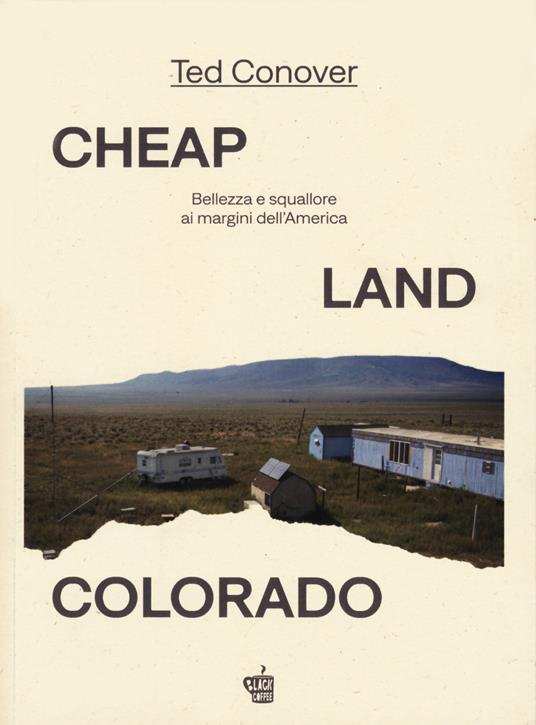
Questa stessa maestosa natura traspare nelle pagine di Cheap Land Colorado, del giornalista Ted Conover, sempre di casa Black Coffee (nella traduzione di Sara Reggiani). Siamo nella San Louis Valley, dove Conover decide di trasferirsi per conoscere da vicino gli Stati Uniti più marginali dopo la vittoria di Trump. Quella di Cheap Land Colorado è un’America sterminata e disperata, fatta di persone attratte dalla promessa di una piccola proprietà privata affacciata su ampi spazi incontaminati, ma che si sono trovate in case precarie, nell’indigenza più profonda, ad arrabattarsi in lavori ai limiti della legalità. Fin dalle prime pagine, la prospettiva di Conover si allontana decisamente dal Wisconsin di Butler, a suon di pallottole vaganti, coltivazioni di marijuana, filo spinato, cani da guardia, fondamentalismi religiosi e terroristi di destra. Dietro questa evidente marginalità, però, si intravede una sottile ma pervicace volontà di cambiamento e, anche in questo caso, un senso di condivisione e comunanza. Il racconto del margine diventa così una domanda, rivolta più a chi ne legge e ne scrive, che a chi lo abita.

In un simile panorama è cresciuto, per poi scriverne, J.D. Vance, scelto da Trump come suo (eventuale) vicepresidente. Nella sua Elegia americana, uscita per Garzanti nel 2017 (nella traduzione di Roberto Merlini), diventata un film diretto da Ron Howard, e disponibile ora anche in audiolibro, Vance si presenta come un trentunenne laureato a Yale, una persona con un lavoro dignitoso, un matrimonio felice, una bella casa e due cani. Ci tiene a sottolineare di non essere un senatore, un governatore o un ex segretario e che quello che il lettore ha davanti è un libro che racconta un percorso normale, un percorso che di solito non appartiene alle persone delle sue condizioni sociali. Vance è cresciuto in Ohio ma la sua famiglia è del Kentucky, e appartiene a quella fetta di popolazione chiamata con disprezzo – e classismo evidente in un’America che si finge estranea ai discorsi di classe – hillbilly, redneck o white trash. Vance ribalta la narrazione rivendicando la sua appartenenza proletaria (e bianca) e una storia famigliare costellata di brutalità. Vance non è superficiale nel suo racconto, riconosce con grande lucidità la deresponsabilizzazione individuale, la sensazione di assenza di controllo nelle scelte, la colpevolizzazione sempre portata verso l’esterno e verso l’altro, ma ammanta la sua narrazione di romanticismo, riconducendo aneddoti e comportamenti a un superiore senso di onore e giustizia proletaria, anche quando in realtà di giustizia ce n’è poca. La sensazione, alla lettura, è inevitabilmente ambivalente e ogni pagina risulta tanto problematica quanto piena di sentimento. Oggi Vance, ex marine ed ex manager, marito di un’avvocata di origini indiane, Usha Chilukuri, dopo un breve flirt con i democratici, ha preferito il fianco di Trump e le sue posizioni politiche, tutt’altro che romantiche, sono sovrapponibili a quelle del – di nuovo – candidato alla presidenza.
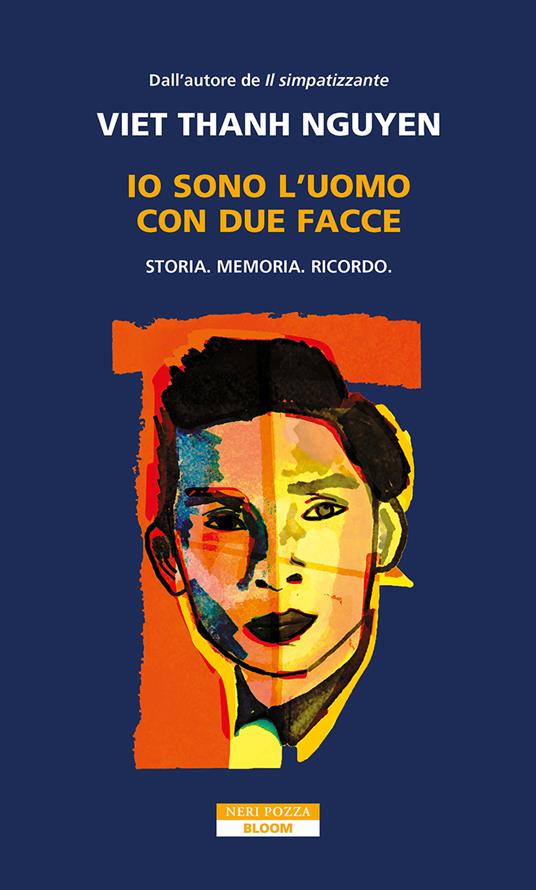
Gli Stati Uniti restano però un paese di migranti: europei, sudamericani, di origine africana o asiatica. Lo raccontano le statistiche e le storie dietro ciascun numero, come quella di Viet Thanh Nguyen, in libreria con Io sono l’uomo con due facce (Neri Pozza, 2024, traduzione di Massimo Bocchiola), una riflessione su identità e memoria. Io sono l’uomo con due facce è un memoir giocato sull’ambiguità insita nella stessa formazione dell’autore, rifugiato ma anche americano, colonizzato e colonizzatore, in un irrisolvibile dualismo. Nel libro di Viet Thanh Nguyen il sogno americano sembra allora uno specchietto per le allodole, rivolto a quella “minoranza modello” che lo statunitense bianco cerca sempre di plasmare a sua immagine. L’aspetto profondamente coloniale della realtà quotidiana degli Stati Uniti è presente fin da subito, così come la rabbia dell’autore, volutamente esibita anche sul piano testuale, con i nomi di Trump e di Obama oscurati e America®, riportato sulla pagina come marchio registrato, un marchio che aderisce a ogni aspettativa di produzione, anche sociale.

Il razzismo, di fatto, può essere raccontato in tanti modi: Teju Cole, acclamato scrittore nigeriano-americano, in Tremore (Einaudi, 2024, traduzione di Gioia Guerzoni) lo fa mettendo in campo un alter-ego, Tunde, un professore universitario di Harvard, di origini nigeriane come l’autore, con un matrimonio punteggiato da tensioni risolvibili con Sadaco, di origini giapponesi. Sia Tunde sia Sadaco sono figli di migrazioni che hanno avuto una conclusione positiva e lo sguardo si poggia sulla quotidianità normale di un uomo colto e affermato professionalmente. Le ferite coloniali emergono qui in due dimensioni, quella domestica e quotidiana, che si esprime in una continua ricerca del proprio sé più intimo e quella estera, che occupa buona parte del libro, durante un viaggio in Nigeria in cui Tunde, anche lui con due facce, torna a casa ma ci torna da straniero colonizzatore. Nelle pagine di Tremore, emerge nitidamente e in ogni aspetto – anche il più laterale – l’esigenza di Cole di decolonizzare gli immaginari, in un’America che sembra non riuscire mai a confrontarsi compiutamente con l’inespresso.
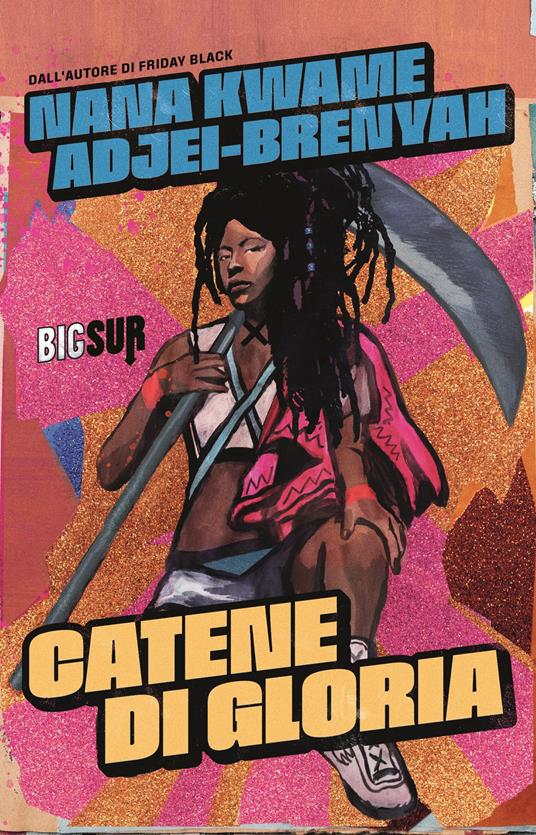
Completamente opposto, invece, l’approccio al tema di un altro autore, Nana Kwame Adjei-Brenyah, che con Catene di gloria (Sur, 2013, traduzione di Dario Diofebi e Martina Testa), il suo primo romanzo, elabora in maniera compiuta le tematiche che aveva già fatto emergere in narrativa breve. Con la forma di un fumettone disturbante, il romanzo di Adjei-Brenyah è ambientato in un futuro prossimo in cui il sistema carcerario è privatizzato e i detenuti condannati con le pene maggiori possono firmare un contratto per accedere a “Catene di gloria”, un raccapricciante format televisivo in cui i carcerati si sfidano in un’arena a suon di armi che chiamare “bianche” proprio non si può. Chi sopravvive passa di livello, di massacro in massacro, fino a conquistarsi la riduzione della pena o la libertà. Questo sadico e spietato gioco è il nuovo reality (ma per certi versi anche il nuovo sport) più amato degli Stati Uniti e, in un delirio capitalistico e di controllo sociale, è seguito sulla pay TV da una cittadinanza completamente assuefatta.
I personaggi sono funzionali alle diverse prospettive del discorso: ci sono le due protagoniste, Loretta Thurwar e Hurricane Staxxx, carcerate e campionesse di “Catene di gloria”, legate da una storia d’amore che è il motore per cercare di sopravvivere al “game” nella disperata speranza di raggiungere insieme la libertà. Ci sono Mari e Nile, attivisti che si battono per far chiudere il format, e poi c’è una popolazione abbruttita, dai fan che partecipano come pubblico sugli spalti a chi non si perde una puntata in televisione, come i coniugi Emily e Will. Gli Stati Uniti di Adjei-Brenyah diventano un incubo distopico, una tecnodittatura utilizzata dall’autore per denunciare le storture di oggi, dalle condizioni carcerarie disperanti, alle violenze che ogni giorno subiscono gli afroamericani, gli immigrati e le persone della comunità lgbtq+, al sistema capitalistico fuori controllo. Resta da chiedersi cosa fare, oggi, di queste storture, che sono solida realtà.
A lettori e lettrici deciderlo: il paesaggio, è idilliaco o in fiamme?
Fonte: www.illibraio.it

